Cammino artistico
Durante questo percorso ho avuto tanti meravigliosi incontri e confronti; è naturale, questi sono stati per me grandi insegnamenti e incoraggiamenti.
Tanti di questi amici oramai se ne sono andati lontano, ma gli incontri aumentano, ci sono tanti amici vecchi e nuovi ancora, che mi rispondono magari con un altro linguaggio.
“
"
Samsara
So che Horiki Katsutomi dipingeva già in Giappone, ma niente posso dire di quel periodo, qualcosa invece del mezzo secolo in Italia.
Lo incontrai che non era arrivato da molto, entro il 1969; presto scrissi qualcosa sulla sua pittura per una mostra alla Promotrice delle Belle Arti di Torino, istituzione secolare che ancora negli anni ‘60/’70 svolgeva una funzione documentaria e propositiva indipendente dal mercato, e per una personale a Messina, in Sicilia. Le prime mostre di Horiki in Italia furono comuni con un gruppo di amici, conosciuti nell’area dell’Accademia, tra i quali spiccava Mimmo Gusmano, pittore e organizzatore, che manteneva rapporti con la Sicilia da cui proveniva e dove era molto stimato. Tutti giovani artisti non coinvolti nella cosiddetta “Arte Povera”, che rappresentava allora l’avanguardia torinese. Per scelta, non per ignoranza, se non altro in quanto Zorio e Penone, protagonisti del movimento, erano stati compagni d’Accademia. I nomi che ritornano con Horiki in diverse occasioni espositive fino alla metà degli anni Settanta – a Torino, Messina, Venezia, perfino nel nord Europa – sono quelli del già nominato Gusmano, di Antonio Freiles, Gianni Del Bue e Pino Mantovani, accomunati dalla volontà di restare fedeli al linguaggio della pittura, alla pittura dipinta, declinata semmai in varianti aggiornate su ricerche internazionali che dall’informale raggiungevano il minimalismo e l’analitico o geplante malerei o peinture-peinture. Horiki non era l’unico pittore giapponese approdato in quegli anni a Torino: diversi nell’arco dei Sessanta seguirono i corsi dell’Accademia Albertina, specialmente Scultura, portando esperienze materiche e operative che lasciarono traccia nella “Arte Povera”.
Mentre altri giovani giapponesi, interessati al design specialmente automobilistico, frequentarono la Bertone, la Pinin Farina ecc. Sul versante artistico, credo sia stata determinante l’attività avviata, a cavallo del ’60, da Michel Tapié, famoso critico francese, teorico dell’Informel e dell’Art Autre, organizzatore abilissimo tra Europa, America e Asia, in particolare Giappone, di eventi ed esposizioni epocali, che aveva fatto di Torino un centro di raccolta e irradiazione assai efficiente. Fu probabilmente la notizia di quel canale di scambio che indusse giovani artisti giapponesi, ansiosi di aggiornamento “occidentalista”, a trasferirsi in una città fino allora abbastanza “a parte”, che pareva destinata a magnifiche fortune e dove operavano e insegnavano artisti presenti nelle Biennali di Osaka e a Tokio, come gli scultori Cherchi e Garelli, a fianco del gruppo Gutai, che proprio a Torino era stato ampiamente mostrato in gallerie di primo piano suscitando il concreto apprezzamento del collezionismo, e nel Museo d’Arte moderna, dotato di una nuova sede e aperto a proposte internazionali.
Horiki non c’entrava con questo fenomeno “ingenuo” di migrazione. Diversa l’età; differenti l’esperienza esistenziale, la cultura, le aspettative. Horiki viene in Italia avendo già messo a punto una compiuta formazione, e avendo vissuto – in una famiglia d’alto rango, quindi specialmente esposta – la crisi che investe il Giappone nel dopoguerra. Che non è soltanto economica, etica e sociale, conseguente al disastro bellico, ma una crisi d’identità avviata da tempo, generata dal contatto inevitabile con il mondo fuori, e dal rapporto problematico con altre culture, tanto allettante quanto difficoltosamente coniugabile con una secolare separatezza. Ma è anche vero che l’Occidente, tanto l’Europa prima quanto l’America poi, subiscono il fascino delle culture orientali e in particolare della variante Giappone. Il citato Michel Tapié favorisce lo scambio di artisti e idee tra Oriente e Occidente, Occidente e Oriente, proprio contando sulla reciproca curiosità e sui vantaggi che ne conseguono, non senza fraintendimenti. Horiki è consapevole che la crisi non è locale ma universale, e non solo negativa. Forse, se non ho male inteso suoi discorsi di allora (la scarsa conoscenza della lingua non gli ha mai impedito di comunicare pensieri complessi, semmai costringendo gli interlocutori a un difficile impegno interpretativo), Horiki viene in Italia e vi si stabilisce, dopo un curioso girovagare che avrebbe potuto depositarlo altrove, per assimilare la miracolosa “certezza”, la misura della tradizione italiana, da Piero della Francesca a Morandi, da Giotto a Sironi e Burri; ma non per fuggire dalla sua tradizione, anzi. In un certo senso, per averne una visione oggettiva dalla distanza necessaria e, se possibile, capire le ragioni strutturali della crisi, e così risalire alla sua natura necessaria, fondamentalmente umana. Quella che le storie particolari hanno sparpagliato e diffuso nel vento delle approssimazioni e nella illusione di identità (e salvezze) separate, esclusive. Se i modelli formali per una soluzione erano da riconoscere nel mirabile Rinascimento classico, e forse da rintracciare in un presente selezionato in mezzo a tante deviazioni e divaricazioni; i contenuti riportavano alle origini: all’uomo stanziale che scopre i problemi del comunicare (il mito della Torre di Babele), all’uomo matematico che dalla misura particolare tenta l’universale (il mito del Centro), all’uomo votato all’abbandono ma anche al ritorno (il mito di Odisseo), all’uomo esploratore dannato alla perdita di sé, a meno che essa non consista nella identificazione con il tutto. Allora, immergersi nelle profondità della cultura occidentale diventa un modo per ritrovare intera la profondità della cultura orientale.
Ma Horiki è stato anche un professionista dell’arte, nel senso più rigoroso e metodico del termine. E su questo piano vale la pena di seguirlo. Dal 1976/’77, dopo un periodo d’assestamento di cui s’è data notizia in avvio, il rapporto di Horiki con il mestiere (dal punto di vista operativo e della distribuzione) si modificò radicalmente. Tre nuove gallerie, destinate a diventare di primo piano a Torino, accolsero sistematicamente il suo lavoro e ne documentarono lo sviluppo in personali e collettive: la Galleria Mantra (poi Tonin), la Galleria Marin (poi Salzano), la Galleria Weber (poi Weber e Weber). Le stesse gallerie ne organizzarono nei decenni successivi la presenza in Fiere internazionali, a Bologna, a Bilbao a Madrid, ecc. Nel ’77 fu invitato per la prima volta alla X Quadriennale di Roma ed iniziò a frequentare Rassegne d’Arte (in particolare fu assiduo al Premio Sulmona, di cui vinse nel 2007 il Primo Premio) e successivamente Simposi d’Arte nazionali e internazionali. Rare e meditate, le mostre personali.
Verso la metà degli anni Novanta Horiki si trasferì da Torino a Cigliano, un piccolo centro del vercellese, dove allestì un ampio studio, per poter realizzare opere di grandi dimensioni (che peraltro non erano mancate anche quando lo spazio disponibile era ridotto) e verificare in loco la coerenza delle varianti su tema. Il metodo, da subito applicato, consisteva nel procedere per cicli: a conclusione di ogni ciclo trovava modo di organizzare personali a documentazione del lavoro compiuto nelle gallerie di riferimento o in altri spazi specialmente adatti, per caratteristiche e valore simbolico: come nel 1994 al Palazzo Pretorio di San Sepolcro, il luogo natale di Piero della Francesca, scelto per la mostra riassuntiva dedicata al ciclo della Vera Croce, o, allargando il campo, nel 2009 a Delft in Olanda, il luogo di Vermeer, scelto per una esposizione di sintesi presso la World Art Delft. A corona, presenze in collettive selezionate e piccole mostre in spazi squisiti di amici, a Alessandria (Triangolo Nero, luogo dell’amico pittore/incisore Gianni Baretta, 1999, 2004, 2011), Treville (Chiesa di San Giacomo, 2005, luogo dell’amico pittore Mario Surbone), Torino (Galleria Mutabilis, luogo che raccoglieva l’eredità dell’amico artista Sergio Agosti).
Particolare attenzione Horiki dedicava ai testi sui cataloghi. Con una costante: quasi sempre i critici coinvolti erano persone con le quali aveva stabilito o stabiliva un contatto amicale, forse meglio un rapporto dialettico. Ogni incontro era occasione per approfondire la consapevolezza del proprio impegno, usando l’intelligenza e la cultura del nuovo interprete. Nella stagione iniziale, gli interlocutori sono gli amici prossimi (Mimmo Gusmano, Pino Mantovani, Giancarlo Salzano, Riccardo Cavallo).
Nella seconda stagione, i rapporti si allargano per ramificazioni: attraverso il gallerista/intellettuale Giancarlo Salzano (anche uno dei suoi primi esegeti) conosce Francesco Bartoli e Gino Baratta, finissimi interpreti, sulla base di una profonda conoscenza delle strutture linguistiche, del sigillo e dell’impronta che caratterizzano la prima stagione matura di Horiki; come Andrea Balzola, Gino Gorza e Alberto Veca, che accompagnano Horiki nel valutare la svolta rappresentata dalla “Storia della Vera Croce”, che si sviluppa e perfeziona nell’arco di un decennio. Nella terza stagione l’incontro con Elena Pontiggia è certo fondamentale: infatti la Pontiggia scriverà ripetutamente di Horiki, portando un contributo essenziale alla interpretazione della vicenda dal ciclo della “Vera Croce”, cui dedica un primo testo pubblicato sul catalogo per la mostra di Sansepolcro, al ciclo della “Odissea”, di fatto dal 1994 alla fine, con un saggio di sintesi che introdurrà, insieme con una breve dichiarazione dell’artista, la monografia postuma di Horiki. Ma è anche una stagione ricca di apporti differenziati per prospettive e metodo d’indagine: che hanno però in comune l’uso della citazione poetica come strumento sinteticamente evocativo dove la lettura fenomenologica, strutturale, iconologica risulta insufficiente o difficoltosa. Non è questa la sede per commentare i commentatori dell’opera di Horiki, ma almeno tre segnalazioni sono necessarie.
La prima trova la sua più completa manifestazione nel saggio di Aart van Zoest che introduce la mostra del 2009 a Delft: in essa, l’autore, giovandosi di nobili riferimenti, Rothko e Opalka, si interroga sulla prossimità di Horiki ai termini da Pierce posti a fondamento della sua semiotica, icona, indice e simbolo, facendo acute osservazioni sulla importanza che ha il comunicare per il pittore giapponese, attraverso l’immagine allusiva se non descrittiva e la parola che l’accompagna. (A proposito di questo devo precisare che Horiki ha usato per anni sigle composte di lettere e numeri, arrivando al titolo solo nel 1984/5).
La seconda, riconoscibile nei saggi di Alberto Veca, di Franca Varallo, della stessa Pontiggia, ci insegna ad osservare con particolare attenzione le infinitesime vibrazioni materiche, di luce e di colore che caratterizzano il lavoro di Horiki, a tutte le distanze e con gli strumenti disponibili, naturali e artificiali. La terza affronta il contenuto mitico che qualifica la pittura (il pensiero in pittura) di Horiki, che preserva fuori dal tempo il valore dell’invisibile come parte essenziale dell’esperienza esistenziale (Gaspare Luigi Marcone, Alessandra Ruffino, Valerie Humbert). Infine, il compositore Alberto Lo Gatto ha proposto una lettura per corrispondenza musicale, da Horiki molto apprezzata, e recentemente Danilo Karim Kaddouri ha tradotto musicalmente il senso dei primi quadri nella composizione Per un’assenza, per due flauti e tamburo rullante (2021).
Testo di Pino Mantovani
Accademia Albertina, Torino
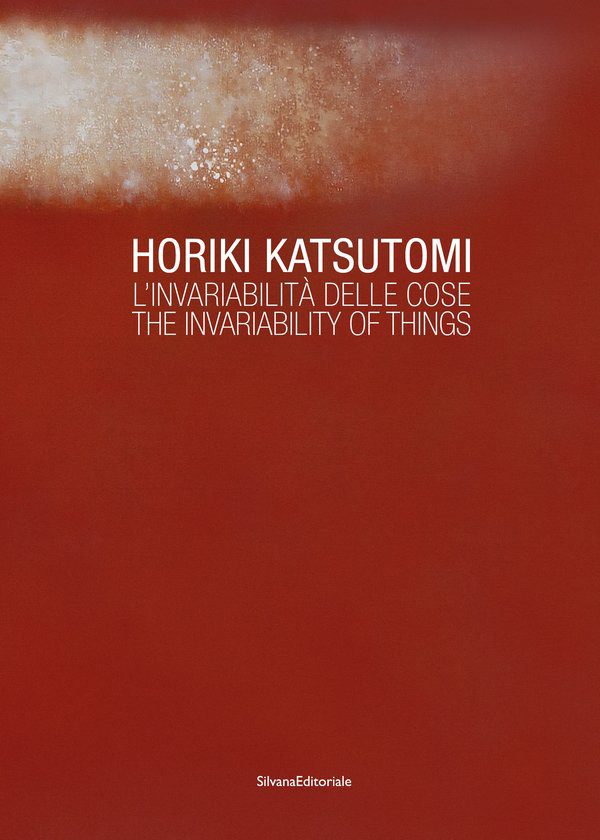
Horiki Katsutomi
L’invariabilità delle cose/The Invariability of Things
2022
Cinisello Balsamo
Silvana Editoriale
ISBN-13. 978-88-366-5056-2
Contattaci





